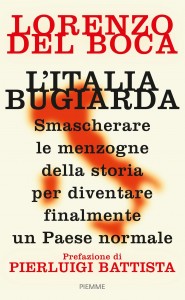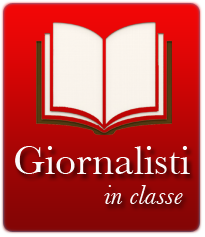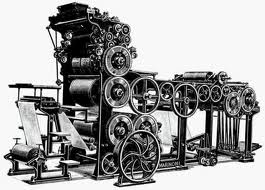

 Enzo Magrì
Enzo MagrìMILANO – La prima riunione dei cronisti milanesi si tenne nel 1877, in un
pomeriggio di luglio. Fu convocata da Francesco Giarelli, redattore
capo della “Ragione” (un giornale radicale che aveva la redazione in
via San Pietro all’Orto 16), nella Fiaschetteria Toscana di Aurelio
Franzetti. All’ordine del giorno non c’erano temi di carattere
sindacale, bensì un problema di marcata rilevanza sociale:
l’atteggiamento che i giornalisti avrebbero dovuto tenere di fronte al
crescente fenomeno dei suicidi.
Alla fine di giugno di quell’anno, i dati statistici del Comune di
Milano avevano messo in rilievo che nel primo semestre c’era stato un
chiaro aumento del numero dei suicidi e dei tentativi di suicidio in
città e nella provincia.
Alcuni medici, e tra questi il professor Gaetano Pini, avevano messo quella lievitazione in relazione con l’eccessiva sottolineatura che la cronaca dava alle informazioni intorno a coloro che avevano deciso di finirla con la vita.
Come oggi si dà la colpa ai mass media per la recrudescenza di alcuni eventi criminali (comparsa di serial killer, delitti a sfondo sessuale, rapine e cosi via), accusandoli di offrire spunti a psicolabili e a criminali per commettere certe nefandezze, cosi allora parecchi sanitari ritenevano che “la frequenza dei suicidi fosse il portato di un fenomeno di suggestione”.
Erano convinti che gli insani gesti sarebbero diminuiti se la stampa quotidiana si fosse risolta a sopprimere le notizie riguardanti quei tragici avvenimenti in quanto la pubblicità, “quella offerta con lusso di particolari”, fosse fatta apposta per sviluppare un pericoloso spirito di imitazione.
Gli scienziati citavano casi nei quali dopo un clamoroso suicidio, esposto, lumeggiato e particolareggiato dai giornali “a pascolo della pubblica curiosità” spessissimo ne seguiva un altro che era la perfetta riproduzione, o quasi, del primo.
Alcuni medici, e tra questi il professor Gaetano Pini, avevano messo quella lievitazione in relazione con l’eccessiva sottolineatura che la cronaca dava alle informazioni intorno a coloro che avevano deciso di finirla con la vita.
Come oggi si dà la colpa ai mass media per la recrudescenza di alcuni eventi criminali (comparsa di serial killer, delitti a sfondo sessuale, rapine e cosi via), accusandoli di offrire spunti a psicolabili e a criminali per commettere certe nefandezze, cosi allora parecchi sanitari ritenevano che “la frequenza dei suicidi fosse il portato di un fenomeno di suggestione”.
Erano convinti che gli insani gesti sarebbero diminuiti se la stampa quotidiana si fosse risolta a sopprimere le notizie riguardanti quei tragici avvenimenti in quanto la pubblicità, “quella offerta con lusso di particolari”, fosse fatta apposta per sviluppare un pericoloso spirito di imitazione.
Gli scienziati citavano casi nei quali dopo un clamoroso suicidio, esposto, lumeggiato e particolareggiato dai giornali “a pascolo della pubblica curiosità” spessissimo ne seguiva un altro che era la perfetta riproduzione, o quasi, del primo.
Per una settimana circa la questione aveva occupato largo spazio nei
fogli cittadini. Alcuni di questi si erano schierati a favore
dell’enunciato degli scienziati. Altri l’avevano contrastato accusando
i medici d’inutile allarmismo.
Per mettere a confronto le due tesi, Giarelli organizza quella che oggi si chiama una tavola rotonda fra i suoi colleghi. Nel 1877 a Milano si pubblicavano dieci giornali. Il più diffuso era “Il Secolo” (quasi 30 mila copie di vendita), nato il 5 maggio del 1866, con sede in via Pasquirolo. Seguivano: “Il Pungolo”, che nella sottotestata recava la scritta “giornale politico popolare”, “La Perseveranza”, conservatore, organo della classe dirigente cittadina; “Il Corriere della Sera”, coeditore proprietario, Eugenio Torelli Viollier; “La Ragione”, diretto da Felice Cavallotti; “La Lombardia”, periodico affidato alla direzione di Emilio Broglio; “l’Unione”, quotidiano della sinistra che appoggiava Depretis; “Il Sole”, organo politico economico fondato da aderenti al partito radicale; “l’Osservatore Cattolico”, foglio politico religioso diretto da don Davide Albertario, e, infine “Lo Spettatore”, di orientamento clerico-liberale.
Per mettere a confronto le due tesi, Giarelli organizza quella che oggi si chiama una tavola rotonda fra i suoi colleghi. Nel 1877 a Milano si pubblicavano dieci giornali. Il più diffuso era “Il Secolo” (quasi 30 mila copie di vendita), nato il 5 maggio del 1866, con sede in via Pasquirolo. Seguivano: “Il Pungolo”, che nella sottotestata recava la scritta “giornale politico popolare”, “La Perseveranza”, conservatore, organo della classe dirigente cittadina; “Il Corriere della Sera”, coeditore proprietario, Eugenio Torelli Viollier; “La Ragione”, diretto da Felice Cavallotti; “La Lombardia”, periodico affidato alla direzione di Emilio Broglio; “l’Unione”, quotidiano della sinistra che appoggiava Depretis; “Il Sole”, organo politico economico fondato da aderenti al partito radicale; “l’Osservatore Cattolico”, foglio politico religioso diretto da don Davide Albertario, e, infine “Lo Spettatore”, di orientamento clerico-liberale.
All’invito di Francesco Giarelli rispondono Daniele Rubbi, cronista
de “La Perseveranza”, Luigi Perelli della “Lombardia”, Luigi Della
Beffa del “Sole”, Vincenzo Broglio e Leopoldo Bignami del “Pungolo”,
Luigi Menghini e Raffaello Barbiera del “Corriere della Sera”, Pietro
Carboni de “L’Unione”, Lorenzo Lertora de “L’Osservatore Cattolico” ed
Aristide Pecchio Ghiringhelli dello “Spettatore”.
La riunione fu disertata dal rappresentante del “Secolo” con una
“comunicazione motivata”. Per dare un formale aspetto d’assemblea a
quel meeting (il quale, per la presenza dei fiaschi sui tavoli avrebbe
potuto essere confuso per una rimpatriata fra amici), sono nominati un
presidente (Vincenzo Broglio) e un segretario (Raffaello Barbiera).
La serietà dell’impegno che tutti vogliono profondere nella trattazione del tema, traspare sin dalle prime battute del dibattito anche se contemporaneamente emerge lo spirito di corpo della categoria usa a pensare “più che con la testa con la testata”. L’antifona si coglie alle prime battute quando i due rappresentanti dei giornali confessionali pongono pregiudiziali di tenore opposto. Lorenzo Lertora informa (“mellifluamente” sottolinea Giarelli) gli astanti che si è presentato per puro spirito di solidarietà e di fraternità giornalistica. Spiega: “Il suicidio, cari colleghi, è, secondo l’Osservatore Cattolico, un delitto come un altro e si deve narrare: e state certi che, per la loro fede cattolica, i lettori dell’Osservatore certamente non imiteranno”.
Gli fa eco Aristide Pecchio Ghiringhelli dello “Spettatore”, il quale sostiene che anch’egli è venuto per non guastare l’armonia fraterna di quella prima adunanza. Ma ammonisce: “Tenete bene a mente che qualunque conclusione dovesse prendere quest’assemblea, essa sarà irrilevante per il mio giornale il quale come non pubblicò prima alcuna notizia sui suicidi e sui tentativi di suicidio così non ne pubblicherà in futuro”.
La serietà dell’impegno che tutti vogliono profondere nella trattazione del tema, traspare sin dalle prime battute del dibattito anche se contemporaneamente emerge lo spirito di corpo della categoria usa a pensare “più che con la testa con la testata”. L’antifona si coglie alle prime battute quando i due rappresentanti dei giornali confessionali pongono pregiudiziali di tenore opposto. Lorenzo Lertora informa (“mellifluamente” sottolinea Giarelli) gli astanti che si è presentato per puro spirito di solidarietà e di fraternità giornalistica. Spiega: “Il suicidio, cari colleghi, è, secondo l’Osservatore Cattolico, un delitto come un altro e si deve narrare: e state certi che, per la loro fede cattolica, i lettori dell’Osservatore certamente non imiteranno”.
Gli fa eco Aristide Pecchio Ghiringhelli dello “Spettatore”, il quale sostiene che anch’egli è venuto per non guastare l’armonia fraterna di quella prima adunanza. Ma ammonisce: “Tenete bene a mente che qualunque conclusione dovesse prendere quest’assemblea, essa sarà irrilevante per il mio giornale il quale come non pubblicò prima alcuna notizia sui suicidi e sui tentativi di suicidio così non ne pubblicherà in futuro”.
Francesco Giarelli ricorda che dopo quel “saggio armonico”, la
discussione si fece “ardente e generale”. “Si torturarono la Filosofia,
la Statistica, la Demografia, la Medicina in pro e contrariamente alla
tesi”. Ci fu chi sostenne essere la minuta descrizione dei suicidi una
remora e non un incitamento alla imitazione. E chi propugnò l’opinione
opposta.
La discussione durò, serrata, animata, un paio d’ore. Esaurite tutte le documentazioni (“e i fiaschi di Chianti”) fu adottato un ordine del giorno proposto da Giarelli e da Perelli. Il documento è una breve antologia di motivazioni adottate per non prendere alcuna decisione. Intanto, assumendo a pretesto l’assenza “volontaria e pretestuosa” del “Secolo” si decise di continuare la pubblicazione delle notizie dei suicidi. Tutti assunsero “l’obbligo di scrivere sull’argomento in modo che mentre si rispettano le convenzioni sociali, si tutelino il segreto e la dignità della famiglia”. Contemporaneamente, fu nominata la “solita commissione incaricata di studiare la questione e di riferire in una seduta successiva”.
La discussione durò, serrata, animata, un paio d’ore. Esaurite tutte le documentazioni (“e i fiaschi di Chianti”) fu adottato un ordine del giorno proposto da Giarelli e da Perelli. Il documento è una breve antologia di motivazioni adottate per non prendere alcuna decisione. Intanto, assumendo a pretesto l’assenza “volontaria e pretestuosa” del “Secolo” si decise di continuare la pubblicazione delle notizie dei suicidi. Tutti assunsero “l’obbligo di scrivere sull’argomento in modo che mentre si rispettano le convenzioni sociali, si tutelino il segreto e la dignità della famiglia”. Contemporaneamente, fu nominata la “solita commissione incaricata di studiare la questione e di riferire in una seduta successiva”.
Di questa struttura furono chiamati a far parte Broglio, Rubbi,
Giarelli e Perelli. I quattro non vennero a capo di niente. Lascio
ancora la parola a Giarelli: “Si capì subito che il sentimentalismo di
chi voleva la soppressione delle notizie sui suicidi aveva dato nelle
secche della pratica. La commissione non aveva dinanzi a sé che un
obiettivo affatto platonico. Non se ne sarebbe fatto più nulla. Né la
cosa poteva differentemente succedere, dal momento che all’adunanza non
aveva voluto dare adesione “Il Secolo”, la cui diffusione superava
allora quella di tutti gli altri giornali milanesi presi assieme. Se
, quindi, avessimo approvata la soppressione delle notizie dei suicidi,
“Il Secolo” non si sarebbe minimamente tenuto vincolato a risoluzioni
cui non aveva partecipato; e ci saremmo trovati perciò di fronte al
pubblico in un’inferiorità informativa incalcolabile, data la
pubblicità che il giornale avrebbe concesso ai suicidi e ai tentativi
di suicidio, che volevansi sopprimere nel notiziario cittadino”.
La riunione nella Fiaschetteria Toscana non fu inutile.
Approfittando di quella prima, sia pure infruttuosa, assemblea fra
cronisti milanesi, il promotore “pronunciò un appropriato discorsetto
in cui mostrava il supremo bisogno dei giornalisti di stringersi gli
uni agli altri coi vincoli della vicendevole assistenza e del mutuo
soccorso”. Presentò un ordine del giorno che fu approvato
all’unanimità. Riconosciuta la necessità di un’associazione
solidaristica fra i redattori dei giornali quotidiani, i presenti
deliberarono di dare mandato ad una speciale commissione “per istudiare
la questione e prendere le misure opportune mettendosi in comunicazione
coll’identica associazione che si sta costituendo a Roma”.
Individualisti come quelli d’oggi (nonostante l’esistenza
d’un’organizzazione sindacale nazionale e locale), i redattori di
allora ubbidivano alla legge della concorrenza che contrapponeva fra
loro i fogli nei quali militavano. Le testate che uscivano a Milano a
ridosso degli anni Ottanta erano il risultato dell’energica selezione
che aveva subito la stampa dopo la fioritura di numerose iniziative
editoriali, frutto dell’euforica “orgia cartacea seguita alla cacciata
degli austriaci”. Allora accadde quello che successe nello stesso
capoluogo lombardo subito dopo il 25 aprile 1945.
Nel volgere di sei mesi (1859), a Milano escono 28 diari politici. I
più interessanti sono quattro. “La Gazzetta di Lombardia”, giornale
ufficioso che si propone di soppiantare “La Gazzetta Ufficiale di
Milano”, che era stato il foglio “d’ordine” degli austriaci. Tuttavia
aveva fatto male i suoi conti. Inaugurando una tradizione, che giungerà
intatta fino al 1945, “La Gazzetta Ufficiale di Milano”, abolita
l’aquila imperiale ed emendata la testata dall’aggettivo “ufficiale”,
continuò le sue pubblicazione. Non saltò neppure una copia: dal 133, il
numero di venerdì 2 giugno, stampato durante il regno austriaco, passò
al 134, quello di sabato 3 giugno, che vide la luce sotto il governo
sabaudo. Una variazione subì il romanzo d’appendice: I principati danubiani furono sostituiti da “I cento anni” di Rovani. Nello stesso mese di giugno uscì “Il Pungolo” di
Leone Fortis che era stato soppresso dall’Austria nel 1858. In novembre
apparve “La Perseveranza”, l’organo della destra milanese.
Strumenti per diffondere opinioni più che informazioni nel paese
appena unificato, dove l’analfabetismo raggiunge vette del 74 per cento
(gli alunni che nell’anno 1863-1864 frequentano le scuole elementari
sono appena 1.100.000 unità), i giornali milanesi assomigliano a quelli
nazionali. Poveri di mezzi, contano, generalmente, quattro pagine e
hanno due diversi formati: quello grande, è di solito di 60 centimetri
per 43; il piccolo, misura 39 centimetri per 27. Gli articoli sono
composti da tipografi i quali utilizzano caratteri mobili che sono
assemblati dentro compositori di legno. Questi saranno successivamente
sostituiti da quelli in ferro, inventati in Francia. Per combinare
lettere e numeri in parole, cifre e righe necessarie e riempire un
foglio di quotidiano, occorrono almeno 12 mila pezzi che un addetto
riesce a mettere insieme nell’arco d’una decina d’ore.
Le pagine, sia quelle dei giornali di piccolo formato sia quelle dei
fogli di grande formato, sono piatte. I titoli quasi sempre ad una
colonna risultano alquanto generici. Lo stile dei pezzi è sovente
trasandato. Qualche volta il testo risulta incomprensibile.
Fatte le dovute eccezioni, nel decennio successivo alla
proclamazione dell’Unità, la stampa italiana, a causa delle magre
condizioni in cui versa e per via delle appassite idealità
risorgimentali, ripiega su impegni municipalistici e clientelari. Il
giornalismo, la gran parte, “si mette al servizio” (come scrive Gaspare
Barbera, editore in Firenze nel 1873) “di chiesuole politiche, prive
dell’appoggio d’una valida maggioranza”. I professionisti (in genere
notai, avvocati, medici) avevano rappresentato il nerbo del giornalismo
patriottico. A partire dal 1859, sono soprattutto gli avvocati e i
procuratori che assumono importanti ruoli nel mondo dei giornali.
Dopo la nascita della Nazione, continuò la commistione tra attività
giornalistica e fervore politico. Il fenomeno consentì ad alcuni
periodici, sovvenzionati dal governo, di restare in vita. Agli ex
avvocati si affiancarono giornalisti, letterati, insegnanti, militanti
politici.
Dario Papa, giornalista del “Corriere della Sera”, agli inizi degli
anni Ottanta si reca insieme con Ferdinando Fontana negli Stati Uniti
per un giro d’orizzonte sulla stampa di quel paese. Al suo ritorno,
oltre a scrivere un libro, New York, abbandona “Il Corriere
della Sera”, lascia le idee monarchico-costituzionali e abbraccia
quelle del centrosinistra. Ammirato, come non poteva non esserlo, del
giornalismo americano, nel suo volume lo pone a confronto con quello
italiano, anzi con il lombardo, che é il più moderno.
“Gli uffici dei giornali americani non sono come i nostri, infestati da una quantità di uomini di lettere che non si sentono nati a fare i piccoli servizi del pubblico, che hanno sempre delle grandi idee da espettorare, ma rifuggono dalla fatica di fare del giornale un veicolo di notizie anziché un’accademia. E cosi avviene che quei giornali là hanno tutti fra loro un tipo diverso e se ne possono leggere parecchi in un giorno sicuri di trovarvi sempre del nuovo. Da noi invece si rassomigliano tutti, eccetto che per le opinioni propugnate. Ci rassomigliamo nelle parlate lunghe e retoriche e magari irte di erudizioni prese dall’Enciclopedia. Ci rassomigliamo nell’infantilità con cui sono fatti i giornali che maggiormente pretendono di avere dello spirito; ci rassomigliamo nell’amore delle rubriche che mettiamo al posto di quello delle notizie”.
“Gli uffici dei giornali americani non sono come i nostri, infestati da una quantità di uomini di lettere che non si sentono nati a fare i piccoli servizi del pubblico, che hanno sempre delle grandi idee da espettorare, ma rifuggono dalla fatica di fare del giornale un veicolo di notizie anziché un’accademia. E cosi avviene che quei giornali là hanno tutti fra loro un tipo diverso e se ne possono leggere parecchi in un giorno sicuri di trovarvi sempre del nuovo. Da noi invece si rassomigliano tutti, eccetto che per le opinioni propugnate. Ci rassomigliamo nelle parlate lunghe e retoriche e magari irte di erudizioni prese dall’Enciclopedia. Ci rassomigliamo nell’infantilità con cui sono fatti i giornali che maggiormente pretendono di avere dello spirito; ci rassomigliamo nell’amore delle rubriche che mettiamo al posto di quello delle notizie”.
Il giornalismo italiano è segnato dall’impronta cavillosa della sua
larga componente avvocatesca e dal tratto aulico dell’altra; la
letteraria. Generalmente, gli articoli sono costruiti secondo i canoni
dell’arringa. Uggiosamente analitici, sono conditi di retorica.
Iniziano in maniera ariosa, si dispiegano fra argomentate premesse e
giungono alla sostanza della questione faticosamente. Tutto il
contrario dello schema espositivo richiesto dal vero giornalismo il
quale esige il metodo sintetico con l’immediata enunciazione
dell’accaduto, corredato dagli elementi che ne accompagnano la
comprensione e l’interpretazione. Questi canoni, che appartengono al
modo di scrivere di oggi, erano osservati dalle agenzie che informavano
con dispacci asciutti.
Buona parte dei giornali italiani, in particolare quelli di
provincia (e gli altri che non avevano mezzi sufficienti per mantenere
un’adeguata struttura redazionale), era fatta con i ritagli di altre
pubblicazioni nazionali ed estere. Sempre Dario Papa, ricorda
l’importante ruolo che svolge “il dottor Forbice” nelle redazioni dei
fogli milanesi. Ora siccome quello del capoluogo lombardo è il
giornalismo per antonomasia, cui la maggior parte dei redattori del
resto d’Italia s’ispira, c’é da ritenere che la figura lumeggiata da
Papa sia un insostituibile primo attore anche negli altri giornali che
si stampano nella Penisola.
Il dottor Forbice, annota il giornalista, è il mattiniero
collaboratore che si dedica allo spoglio dei giornali. Egli lavora “da
filosofo, senza scomporsi, menando colpi di forbice a dritta e a manca,
tagliando il mondo a pezzetti e a pezzettini cui dispone in ordine sul
tavolo per poi consegnarli, ben titolati al proto, accorciando di qui,
combinando le notizie dei vari giornali, segnando col lapis questo
articolo d’un giornale per il direttore, quest’altro per il cronista,
quest’altro ancora per l’appendicista a seconda delle diverse
attribuzioni; sfogliandoli uno a uno, e dando, con una rapidità nota a
lui solo, una occhiata a tutti e singoli settanta od ottanta giornali
che gli stanno dinanzi, anche a quelli delle più oscure città di
provincia e cogliendo, sicuro, come l’artiglio d’un falco, una
notizietta buona, seppellita in mezzo a un deserto di inutilità, per
trasportarla nel giornale proprio”.
Per la gran parte, il mondo della carta stampata ha ancora un taglio
artigianale. Il dilettantismo marchia la componente redazionale e
quella editoriale. Qui non mancano i gabba mondo. Illuminante l’analisi
di Fra Zeno nel suo Quarto potere (1889) su come e perché
nascono certi fogli. “L’individuo che si sente votato alla direzione di
un giornale proprio, se ha quattrini fonda “Il Globo”, “l’Universo”,
“Il Paese” od altro periodico dal titolo ampolloso.
Se tale individuo è povero in canna, va in cerca d’un tipografo di buona fede, d’un fabbricante di carta credenzone e di collaboratori che sappiano e possano attendere, anche a lungo, uno stipendio iperbolico. Trovati i merli, il predestinato alla proprietà e direzione di un giornale, mette alla luce, putacaso, l’”Asmodeo”, come punterebbe l’ultimo napoleone su una carta. Se il pubblico, mordendo all’amo, acquista il nuovo giornale, la speculazione può considerarsi come avviata ed il direttore proprietario tira innanzi fidando nella Dea Bendata. Se, viceversa, il gemito della macchina tipografica fu gemito buttato e le copie del neonato periodico finiscono dal pizzicagnolo, l’improvvisato direttore proprietario si eclissa lasciando a mani vuote e naso allungato il tipografo, il cartaio ed i poco avventurati sacerdoti del «quarto potere» che avevano accettato di essere collaboratori”.
Se tale individuo è povero in canna, va in cerca d’un tipografo di buona fede, d’un fabbricante di carta credenzone e di collaboratori che sappiano e possano attendere, anche a lungo, uno stipendio iperbolico. Trovati i merli, il predestinato alla proprietà e direzione di un giornale, mette alla luce, putacaso, l’”Asmodeo”, come punterebbe l’ultimo napoleone su una carta. Se il pubblico, mordendo all’amo, acquista il nuovo giornale, la speculazione può considerarsi come avviata ed il direttore proprietario tira innanzi fidando nella Dea Bendata. Se, viceversa, il gemito della macchina tipografica fu gemito buttato e le copie del neonato periodico finiscono dal pizzicagnolo, l’improvvisato direttore proprietario si eclissa lasciando a mani vuote e naso allungato il tipografo, il cartaio ed i poco avventurati sacerdoti del «quarto potere» che avevano accettato di essere collaboratori”.
Anche se questa che illustra Fra Zeno è una situazione al limite, la
condizione della maggior parte dei giornali è davvero precaria. La
redazione è generalmente formata dal direttore e da un paio di
redattori: uno che si occupa degli esteri, l’altro degli interni.
Quanto alle fonti d’informazione, esse sono principalmente gli altri
giornali, l’agenzia Stefani (per le aziende che se la possono
permettere) e i corrispondenti “che di solito sono amici del direttore
i quali scrivono lunghe e sgrammaticate lettere”.
Privi d’inquadramento professionale e salariale, i giornalisti sono
considerati “agenti o commessi degli editori”. Le strutture delle
nostre redazioni sono mediamente scarne rispetto a quelle straniere. La
“Neue Freie Presse” di Vienna occupa 600 dipendenti (tra questi
figurano 50 tra redattori e collaboratori interni, 120 corrispondenti
dall’interno e altrettanti dall’estero e 150 impiegati esclusi gli
operai).
Il “Corriere della Sera” negli anni dell’esordio dispone di 123 dipendenti: 16 redattori, 10 impiegati, 44 tipografi, 47 speditori e distributori e 6 portieri. Benché per fare un giornale come il foglio di via Solferino nel 1889 si spendano 177 mila lire l’anno, i compensi per i giornalisti sono una componente marginale.
Il “Corriere della Sera” negli anni dell’esordio dispone di 123 dipendenti: 16 redattori, 10 impiegati, 44 tipografi, 47 speditori e distributori e 6 portieri. Benché per fare un giornale come il foglio di via Solferino nel 1889 si spendano 177 mila lire l’anno, i compensi per i giornalisti sono una componente marginale.
A quel tempo non sono più di quattro i direttori di giornale che
guadagnano seimila lire l’anno, vale a dire cinquecento lire il mese.
Cavallotti, quando dirigeva il “Gazzettino Rosa”, ne percepiva
trecento; Silvio Spaventa, riceveva per ogni articolo che scriveva
centocinquanta lire. Fatta eccezione per le personalità professionali,
tutti gli altri ricevevano emolumenti meschini. Con quello che
guadagnavano facendo i redattori, molti non sarebbero potuti
sopravvivere se non avessero fatto un’altra professione. In parecchi
casi erano anzi i giornalisti che finanziavano i giornali acquistando
carature della testata.
Francesco Giarelli ricorda che non era raro che il giornalista fosse
pagato in natura. Incaricato di scrivere articoli di fondo per il
“Monitore dei droghieri” per un compenso di dieci lire, egli stesso,
dopo il primo numero, si vide versare la collaborazione in generi di
salsamenteria. Andato a riscuotere la retribuzione, trovò il
committente, il signor Vincenzo Torta, con un cartoccio di prodotti che
gli sciorinò su un tavolo. C’erano: un chilogrammo di caffè, un
chilogrammo di zucchero, due pacchi di steariche, sapone, essenza di
gelsomino, bottiglie di Malaga, Madera, Alicante, amido, lucido per le
scarpe, due spugne, un pacchetto di tè, cicoria, gomma profumata e
pasta di Napoli.
La mancanza di mezzi si riverberava ovviamente su tutti i “settori”
del giornale, in particolare sull’organizzazione della cronaca
cittadina. Diversamente dal resto della redazione, questa era però
sostenuta da una scrittura si può dire “moderna” mutuata da una sorta
d’involontaria lezione di giornalismo che il mestiere milanese aveva
ricevuto ed ereditato dalla pignoleria degli austriaci.
Per offrire ai giornali, “organi di governo”, informazioni
“all’oggetto di eccitare l’interesse dei lettori”, l’imperiale ministro
dell’Interno aveva incaricato della raccolta delle notizie la Questura,
il Municipio e la Camera di Commercio. Il dicastero aveva emanato
successivamente una circolare con la quale esemplificava come in
funzionari dei tre uffici avrebbero dovuto scrivere quelle note. Per
evitare che trascendessero nelle forme retoriche e letterarie in voga
all’epoca, gli estensori erano stati muniti d’un formulario. I diversi
modelli d’annuncio andavano dalla morte d’un ultracentenario (Salomone N. d… è morto nell’avanzata età di 113 anni), all’incendio d’una cascina (un incendio, di cui s’ignora la causa, è scoppiato …); dalla visita dell’autorità alle reclute d’una caserma, all’esecuzione di “un traditore” (Lunedì
9 corrente, venne passato per le armi a… l’avvocato N… di… nella
cui abitazione fu trovata una quantità di armi nascosta. Il vescovo di
… e parecchi rispettabili personaggi si erano, ma invano, interessati
per salvargli la vita. Il supplizio di questo causidico fece una
straordinaria impressione…”.
Nonostante il prontuario che anticipa di almeno un secolo certe
regole del giornalismo moderno (quello delle cinque W, per intenderci),
sui giornali milanesi dell’Italia appena nata, scarseggia la cronaca,
nera o bianca che sia. La narrazione dei fatti accaduti in città era
stata praticamente inventata agli inizi dell’Ottocento da madame Ester
Guimont. Bella, spiritosa, elegante, la signora era amica di Balzac e
di Dumas i quali frequentavano il suo salotto insieme con il mondo
elegante parigino. Pare che sia stata proprio lei (lo racconta Balzac) a dare ad un
redattore del “Constitutionnel”, lo stesso giornale che inventerà il
feulletton, il consiglio di raccogliere in una speciale rubrica tutto
ciò che accadeva nella capitale francese.
Il nuovo modo di fare giornalismo approderà con molto ritardo nel
capoluogo lombardo. La prima notizia di cronaca pubblicata dal paludato
giornale “La Perseveranza””(un crollo), risale al 14 dicembre 1861,
vale a dire 748 giorni dopo la sua prima uscita. Successivamente, i
fatti del giorno saranno radunati sotto due rubriche (una nazionale,
l’altra di rilievo cittadino) intitolate Notizie varie e Notizie
cittadine.
Ad introdurre sistematicamente e organicamente la cronaca nelle
pagine d’un giornale milanese, fu agli inizi degli anni ’70, Carlo
Romussi del “Secolo” (diretto da Teodoro Moneta) attraverso un’attiva
squadra di reporter. Miniscolo, sfacciato e permaloso, baffi spioventi
e occhiali a pince-nez, Romussi era un assiduo dell’osteria la Patona e per questo motivo era stato soprannominato Bardolino.
Divenuto capocronista (“l’uomo più combattente e più combattuto del
mondo politico giornalistico milanese”), si serviva di parecchi
informatori. La sua cronaca faceva perno su un gruppo di reporter
assunto stabilmente.
L’impronta popolare, l’oculata amministrazione, la macchina a stampa
Marinoni, ma soprattutto l’ampio ventaglio di notizie che la sua
cronaca offriva, contribuirono all’affermazione del “Secolo” che nel
1871, in una Milano che contava duecentoquarantaseimila abitanti, aveva
soppiantato il “Pungolo” di Leone Fortis. Prima che l’avvocato Carlo
Romussi pubblicasse quotidianamente e sistemarticamente ciò che era
successo nel capoluogo il giorno precedente attraverso l’operoso staff
dei suoi redattori, la cronaca cittadina (quella nera e quella bianca)
dei diversi fogli, era monopolio d’un pool di quattro persone.
Della nera si occupava Vincenzo Broglio. Cinquantenne, ex
garibaldino, lavorava come cronista al “Pungolo”, ma raccoglieva le
notizie per la sua e per le altre testate. Fonte principale era
naturalmente la Questura. Sistemato dapprima nei locali dell’ex sede
della polizia asburgica, in via Santa Margherita 16, il comando del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza era stato insediato nel 1871
in piazza San Fedele, nel convento che era appartenuto ai Gesuiti.
Broglio vi si recava tutte le mattine. Qui, in un apposito “libro
nero”, trovava segnati e riassunti i dati dei rapporti che arrivavano
dai mandamenti della città e le relazioni delle varie sezioni di Ps.
All’inizio della carriera da solo, successivamente con l’aiuto di un
giovanotto, certo Bruni (che poco più tardi abbandonò la carriera di
reporter per fare l’agente teatrale), il giornalista del “Pungolo” copiava i rapporti che passava anche agli altri colleghi. Capitava
spesso che l’ex garibaldino e il suo aiutante indugiassero diffusamente
su fatterelli banali e tralasciassero eventi più gravi con la scusa che
su quei fatti “era stato mantenuto il silenzio più assoluto perché con
notizie premature non si doveva intralciare l’opera dell’istruttoria
giudiziaria”. Sostenuto però dall’egregio suo servizio di
“riportaggio”, il “Secolo” pubblicava all’indomani la faccenda grossa
spingendo i giornali che avevano patito lo scoop a protestare con i due
reporter i quali non sapevano fare altro che “mandare a quel paese la
Questura e il suo servizio informazioni”.
La fonte della cronaca bianca era naturalmente il Comune. Ad
attingervi le notizie era un impiegato dello stato civile. Felice
Venosta, nobile, “veterano delle patrie battaglie”, aveva scritto una
storia popolare delle Cinque Giornate e collaborava alla Collana dei
Martiri Italiani, una raccolta in volumetti.
Corrispondente ufficiale del “Secolo”, che gli passava un assegno speciale, distribuiva informazioni anche alle altre cronache ma per mezzo d’un impiegato municipale, ufficiale sanitario in forza alle pompe funebri, certo Luigi Bellerio. Sollecitato dai cronisti, che ambivano a restituire parte dei “buchi” che subivano dall’imbattibile primo quotidiano cittadino, non di rado il burocrate esagerava. Anziché limitarsi a fornire soltanto le notizie comunali, compiva incursioni nel campo della nera. Apportando marginali modifiche alla sua tenuta d’impiegato (uniforme nera, sciarpa bianca, bandoliera e luma nel cappello a cencio), si faceva passare per un poliziotto e riusciva ad estorcere informazioni riservate agli agenti veri oppure a protagonisti e a testimoni dei crimini accaduti. Lo slancio di rendersi utile, o più probabilmente la brama del compenso, spingevano il funzionario a strafare e ad inventare particolari imbarazzanti per i giornali che si servivano della sua collaborazione.
Corrispondente ufficiale del “Secolo”, che gli passava un assegno speciale, distribuiva informazioni anche alle altre cronache ma per mezzo d’un impiegato municipale, ufficiale sanitario in forza alle pompe funebri, certo Luigi Bellerio. Sollecitato dai cronisti, che ambivano a restituire parte dei “buchi” che subivano dall’imbattibile primo quotidiano cittadino, non di rado il burocrate esagerava. Anziché limitarsi a fornire soltanto le notizie comunali, compiva incursioni nel campo della nera. Apportando marginali modifiche alla sua tenuta d’impiegato (uniforme nera, sciarpa bianca, bandoliera e luma nel cappello a cencio), si faceva passare per un poliziotto e riusciva ad estorcere informazioni riservate agli agenti veri oppure a protagonisti e a testimoni dei crimini accaduti. Lo slancio di rendersi utile, o più probabilmente la brama del compenso, spingevano il funzionario a strafare e ad inventare particolari imbarazzanti per i giornali che si servivano della sua collaborazione.
Un’informazione cosi vaga e malsicura procurava non pochi infortuni
al giornalismo cittadino. La frequenza del fenomeno è evidenziata da
questa storiella che Paolo Ferrari, spirito caustico e autore
drammatico di successo, amava ripetere. “Se il «Pungolo» annuncia oggi
che tu sei stato travolto sotto una carrozza in piazza del Duomo
rimanendone ucciso; e domani tu stesso, in carne e ossa, vai a pregare
il «Pungolo», vai a pregare Broglio, il papa della cronaca cittadina,
che rettifichi, egli metterà, tutt’al più, brontolando, un secondo
articoletto intitolato Nuovi Particolari che dirà a un di
presso così: Abbiamo naturalmente continuato ad assumere informazioni
intorno al triste fatto di piazza del Duomo, ieri assai succintamente
narrato e con piacere siamo venuti a conoscere la conferma (sic) del
fatto aggiungendovi anzi che il nostro egregio amico non solo non è
morto, per causa di quel malnato brumista del numero tale, ma sta bene
ed ha presentato il dovuto reclamo alla questura. Egregiamente; così va
fatto”. (Tabloid n. 1/2004)